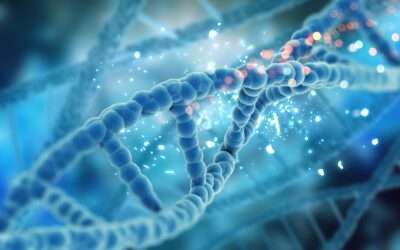Premio tesi ISSA Europe: i lavori vincitori 2025 e nuova edizione al via
24 Ottobre 2025

Il Premio Tesi di Laurea ISSA Europe anche nel 2025 ha rappresentato un appuntamento importante. L’evento. ormai consolidato nel tempo, è stato pensato per valorizzare la ricerca accademica e i giovani professionisti del settore fitness e sport. L’iniziativa mette in palio un montepremi che supera i 5.000 euro tra contributi economici e opportunità formative, confermando il concreto impegno di ISSA verso la ricerca scientifica, l’innovazione e lo sviluppo di nuove competenze.
Con settembre è già partita la raccolta dei lavori per l’edizione 2026 del Premio. Studenti e neolaureati possono presentare i propri elaborati, che mirano a unire rigore scientifico e applicazione pratica nel mondo del movimento umano.
In questa edizione 2025, i progetti premiati si distinguono per l’originalità degli approcci, la solidità metodologica e la rilevanza dei temi trattati.
Gli abstract dei lavori vincitori, che riportiamo integralmente di seguito, offrono una panoramica delle nuove frontiere di studio che stanno arricchendo il panorama del fitness. Gli argomenti vanno dal sovraccarico eccentrico all’allenamento femminile, dall’attività fisica adattata contro l’osteoporosi fino agli effetti della coerenza respiratoria sull’HRV e sul benessere psicofisico.
Contenuti della pagina
Primo Premio Tesi ISSA Europe 2025 a Giulia Tomasi
È noto che il muscolo scheletrico possiede una capacità di generare forza significativamente maggiore durante la contrazione eccentrica rispetto alla concentrica. Nello specifico, nella contrazione concentrica il muscolo si accorcia per generare forza vincendo la resistenza esterna imposta, invece, nella contrazione eccentrica il muscolo si allunga mentre genera forza opponendosi ad un carico esterno.
Nonostante questa superiore capacità di generare forza in fase eccentrica, la maggior parte degli esercizi di resistenza convenzionali impiega un carico costante per entrambe le fasi della contrazione.
Questo approccio, sebbene pratico e diffuso, porta a un sottoutilizzo della fase eccentrica, in quanto il carico scelto è generalmente calibrato sulla forza esprimibile nella fase concentrica. Di conseguenza, la fase eccentrica viene svolta con un’intensità relativa minore, determinando una ridotta attivazione neuromuscolare e un minor numero di unità motorie reclutate rispetto a quanto il muscolo potrebbe effettivamente sostenere.
Questa discrepanza ha portato a ipotizzare un approccio diverso all’allenamento, basato su un sovraccarico eccentrico, che possa offrire vantaggi significativi in termini di attivazione muscolare, adattamenti neurali e incremento della forza.
L’importanza del sovraccarico eccentrico nell’allenamento muscolare: un nuovo approccio all’adattamento neuromuscolare
Per indagare gli effetti sopra riportati, si è condotto uno studio sperimentale su un campione di 16 giovani adulti sani, composto da 8 donne e 8 uomini con età compresa tra i 18 e i 30 anni.
I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi omogenei. Un gruppo ha seguito un protocollo di allenamento convenzionale. Mentre l’altro ha eseguito un protocollo con sovraccarico eccentrico.
Entrambi i gruppi si sono allenati per 6 settimane, con tre sedute settimanali, utilizzando come esercizio la Leg Press modello REV della Technogym, eseguita in modalità monolaterale. Tale macchina permette di applicare un sovraccarico dell’intensità prestabilita nella fase eccentrica.
L’uso dell’HDsEMG
Un elemento di particolare innovazione in questo studio è rappresentato dall’utilizzo dell’elettromiografia di superficie ad alta densità (HDsEMG) come metodo di analisi.
Questa tecnologia avanzata consente di acquisire segnali elettrici dal muscolo con una risoluzione molto elevata, grazie a una griglia di elettrodi applicata sulla pelle.
Inoltre, attraverso sofisticati algoritmi di decomposizione dei segnali, è possibile analizzare l’attività elettrica delle singole unità motorie, offrendo così una visione dettagliata e quantitativa del reclutamento delle unità motorie durante l’esercizio.
Obiettivi e prospettive dello studio
L’ipotesi principale dello studio è che l’allenamento con sovraccarico eccentrico possa determinare adattamenti neuromuscolari maggiori e duraturi rispetto a un protocollo tradizionale. In particolare, ci si aspetta una maggiore stabilizzazione dell’attività delle unità motorie, un incremento della loro capacità di scarica e un miglioramento del coordinamento neuromuscolare. Questi elementi nel loro insieme contribuiscono all’aumento della forza muscolare. In conclusione, i risultati attesi da questo studio potrebbero avere importanti implicazioni pratiche.
L’obiettivo a lungo termine è quello di validare protocolli di allenamento basati sul sovraccarico eccentrico come strumento efficace, sicuro e versatile, applicabile a diverse categorie della popolazione.
In particolare:
- atleti: per massimizzare la performance sportiva attraverso un miglioramento rapido della forza e della potenza.
- pazienti in fase post-operatoria o riabilitativa: per favorire un recupero più efficiente.
- anziani: per contrastare la perdita di massa e forza muscolare (sarcopenia), con esercizi meno faticosi ma più efficaci in termini di stimolo neuromuscolare.
Conclusioni
Lo studio intende quindi fornire evidenze scientifiche a supporto dell’adozione di questi protocolli nella pratica clinica e sportiva, sottolineando l’importanza di un approccio personalizzato e basato sulla fisiologia del muscolo. L’integrazione di tecniche avanzate di analisi, come l’HDsEMG, consente non solo di monitorare con precisione gli effetti dell’allenamento, ma anche di aprire nuove strade per la valutazione e l’ottimizzazione dei programmi di esercizio.
Secondo premio Tesi ISSA 2025 a Luana Ciabreli
Il progressivo aumento dell’aspettativa di vita nella popolazione femminile non sempre coincide con un incremento proporzionale della qualità della vita. Le donne vivono più a lungo, ma spesso con un maggior numero di anni trascorsi in condizioni di fragilità o disabilità.
Le cause sono multifattoriali: predominano patologie osteoarticolari, cardiovascolari e neuro-psicologiche, le cui incidenze risultano aggravate in età post-riproduttiva. In tale contesto, l’allenamento della forza si configura come uno strumento preventivo, terapeutico e funzionale alla promozione del benessere biopsicosociale nelle donne in ogni fase della vita.
La forza delle donne: evidenze e protocolli per il potenziamento muscolare femminile attraverso le fasi della vita
La tesi di laurea di Luana Ciabreli, intitolata “La Forza delle Donne: come incrementarla dall’adolescenza all’età senile”, affronta in modo trasversale il ruolo dell’allenamento della forza nelle donne. L’obiettivo è indagare benefici, modalità applicative e adattamenti nelle diverse stagioni biologiche del corpo femminile.
Il lavoro si sviluppa su progetto sperimentale sul campo, con un programma annuale di allenamento supervisionato su 6 soggetti rappresentativi di differenti fasi della vita.
Il corpo femminile in movimento: cosa cambia e perché allenare la forza
La prima parte del lavoro analizza la fisiologia femminile e le implicazioni motorie nelle fasi di post pubertà, gravidanza, post gravidanza, menopausa e post menopausa. Le variazioni ormonali (in particolare gli sbalzi estrogenici) condizionano profondamente la salute ossea, muscolare e metabolica.
La sedentarietà, ancora troppo diffusa nel pubblico femminile, rappresenta un ulteriore fattore aggravante. L’allenamento della forza, lungi dall’essere esclusivo ambito maschile o agonistico, ha oggi solide evidenze a supporto. In particolare, l’allenamento delle donne in menopausa aumenta la massa magra, stimola la densità minerale ossea (BMD), migliora la sensibilità insulinica, riduce i paramorfismi e migliora le capacità motorie funzionali.
Particolarmente rilevante è il suo effetto sull’equilibrio, sulla prevenzione delle cadute e sul mantenimento dell’autonomia motoria in età avanzata. A livello psico-sociale, si registrano effetti positivi su autostima, umore, qualità del sonno e resilienza emotiva.
Metodo sperimentale: struttura del progetto
Il caso studio ha coinvolto sei donne, tra i 25 e gli 82 anni, suddivise in cinque fasi chiave della vita femminile.
Tutte le partecipanti sono state sottoposte a un percorso annuale di allenamento della forza, strutturato in un macrociclo suddiviso in quattro mesocicli trimestrali. Ciascuno di essi aveva progressione individualizzata di intensità, volume e densità.
Si sono applicati metodi misti: sovraccarico isotonico (piramidale), circuit training e PHA (Peripheral Heart Action). Ogni mesociclo è stato preceduto e seguito da una batteria di test motori adattati dal protocollo Eurofit, focalizzati sulla forza esplosiva (arti inferiori), forza resistente (arti superiori e busto), forza veloce (test di lancio) e test funzionali lattacidi.
I dati raccolti hanno permesso di monitorare l’evoluzione prestativa, la risposta agli stimoli e gli eventuali aggiustamenti individuali.
Risultati: incremento trasversale e adattamenti specifici
I dati emersi dimostrano un miglioramento trasversale in tutti i soggetti, indipendentemente dall’età di partenza.
Si è osservato un incremento medio nei test di forza variabile dal +12% al +35% in funzione del distretto muscolare, della fase di vita e della condizione iniziale. Le progressioni più rapide si sono registrate nei primi 3–6 mesi, coerentemente con la letteratura sull’adattamento neuromuscolare iniziale.
Le partecipanti in menopausa e post menopausa hanno mostrato netti miglioramenti in termini di forza resistente e stabilizzazione posturale, con effetti benefici sull’equilibrio statico e dinamico.
Nei soggetti anziani (72 e 82 anni), l’allenamento si è confermato determinante nel mantenimento della funzionalità quotidiana e della mobilità articolare, riducendo il rischio di cadute.
Nel soggetto post gravidanza, il lavoro mirato ha contribuito al recupero del core (incluso il trattamento della diastasi addominale) e al rafforzamento del pavimento pelvico.
La forza al femminile come alleato per benessere, consapevolezza e relazione
Questo studio vuole mostrare quanto sia importante inserire l’allenamento della forza, adattato e progressivo, nel percorso di benessere femminile lungo tutto l’arco della vita.
La forza non è soltanto una qualità muscolare: è una risorsa globale, che sostiene l’autonomia, la vitalità, l’autostima e la fiducia in sé stesse. Durante l’anno di lavoro si è cercato, con rigore metodologico e attenzione empatica, di costruire un’esperienza che fosse non solo efficace, ma anche significativa per le donne coinvolte.
Attraverso un’attenta osservazione delle tecniche sportive e dei principi di insegnamento, si sono posti al centro i bisogni individuali, i vissuti, i cambiamenti legati all’età e soprattutto la relazione. Si è comunicato con semplicità, motivandosi vicendevolmente, selezionando obiettivi realistici e costruendo situazioni di apprendimento stimolanti e piacevoli. Le donne attraversano fasi biologiche complesse, che non vanno vissute come un declino, ma come trasformazioni da accogliere e accompagnare.
Allenarsi in modo consapevole significa prendersi cura di sé con rispetto, con coraggio e con fiducia. Molte donne temono che l’allenamento con i pesi possa compromettere la loro femminilità. È una credenza ancora diffusa, alimentata da anni di disinformazione.
Conclusioni
La realtà è che con i giusti criteri di pianificazione, adattamento e ascolto, l’allenamento con i sovraccarichi si dimostra uno strumento potente per migliorare l’aspetto estetico, la postura, l’umore e soprattutto il senso di padronanza sul proprio corpo. Il metodo applicato ha portato risultati concreti: non solo in termini di performance o composizione corporea, ma soprattutto nel consolidamento del benessere psicofisico e sociale.
L’ambiente che si è creato è stato positivo, inclusivo, gratificante. Sono convinta che questo approccio si possa estendere anche a soggetti con disabilità, favorendo il superamento dell’isolamento e il mantenimento del legame con gli altri attraverso il movimento. Per questo è fondamentale che la cultura del corpo si faccia sempre più accogliente, capace di rispecchiare e valorizzare la diversità dei corpi, delle storie, delle età. Perché ogni donna ha il diritto di sentirsi forte, a modo suo.
Secondo premio Tesi ISSA 2025 a Michele Scavio
L’osteoporosi a oggi è la più comune delle malattie metaboliche delle ossa ed è una malattia di rilevanza sociale. Non possiamo quindi, in quanto chinesiologi ed educatori del movimento, non tener conto dell’importanza dell’esercizio fisico adattato sia a livello preventivo che nel rallentamento dei processi metabolici che causano l’osteoporosi. L’obiettivo della tesi in questione è stato quello di esaminare la letteratura scientifica in modo da avvalorare l’importanza dell’impatto dell’esercizio fisico adattato sul rallentamento dell’osteoporosi nella popolazione anziana.
L’elaborato si basa, infatti, sulla ricerca e studio di molteplici articoli scientifici pubblicati prevalentemente nel corso dell’ultimo quinquennio per avere evidenze scientifiche attuali.
L’impatto dell’attività fisica adattata sul rallentamento dell’osteoporosi nella popolazione anziana
Tra gli studi che particolarmente significativi, si può citare lo studio di Hsu et al. (2024), che mirava ad esaminare i benefici dell’aggiunta di esercizio a farmaci/integratori nelle donne in post-menopausa. I risultati hanno mostrato un miglioramento significativo della densità minerale ossea nella colonna lombare combinando più tipi di allenamento fisico.
Inoltre, l’allenamento aggiuntivo ha migliorato significativamente la forza muscolare degli arti inferiori, la scala dell’equilibrio di Berg, il Timed Up and Go, la paura di cadere e la qualità della vita.
Nel complesso, il valore significativo dell’esercizio è stato dimostrato dallo studio di Hsu et al. (2024) attraverso il miglioramento delle prestazioni fisiche e della qualità della vita, insieme all’efficacia della combinazione dei programmi di allenamento.
Dallo studio di Watson et al. (2018) è emerso invece che l’allenamento di resistenza progressiva ad alta intensità e di impatto sul peso, di breve durata e svolto due volte a settimana, è risultato sicuro, efficace e migliore rispetto ai tradizionali approcci conservativi a bassa intensità. Le 101 partecipanti hanno migliorato infatti la densità minerale ossea della colonna lombare, del collo del femore, la funzionalità fisica e la statura.
Lo studio di Wu et al. (2024) ha invece esaminato la relazione tra i vari tipi di esercizi di impatto e l’osteoporosi utilizzando i dati della Biobanca di Taiwan.
Esercizio ad alto o basso impatto?
I risultati hanno indicato che l’esercizio ad alto impatto ha ridotto significativamente la possibilità di sviluppare l’osteoporosi rispetto a nessun esercizio. Al contrario, gli esercizi a basso impatto non hanno mostrato un’associazione significativa con l’osteoporosi.
La meta-analisi di rete di Zhang et al. (2023) ha invece mostrato che l’esercizio combinato, l’esercizio di contro resistenza, l’esercizio aerobico e l’esercizio mente-corpo hanno avuto un effetto significativo nel migliorare la densità ossea della colonna lombare e del collo femorale. Rispetto a quest’ultimo, l’esercizio ottimale era quello mente-corpo.
Inoltre, è emerso che l’esercizio aerobico e l’esercizio di contro resistenza potrebbero migliorare la densità minerale ossea totale dell’anca, con l’esercizio di contro resistenza classificato al primo posto.
Whole body vibration
Infine, lo studio di Li et al. (2024) ha mostrato che la WBV (whole-body vibration) può aumentare significativamente la densità minerale ossea della colonna lombare e del collo femorale e ridurre il grado di dolore nella PMOP. Questo, però, non ha effetti significativi sulla massa muscolare dei pazienti né sulla massa grassa.
Dai risultati è emerso che la WBV ha dimostrato il potenziale di apportare benefici positivi nel migliorare la densità minerale ossea e nell’alleviare il dolore dell’osteoporosi post-menopausale.
Già solo menzionando questi articoli si può osservare l’eterogeneità degli studi e dei percorsi di allenamento proposti, nonché le differenze circa la loro intensità e durata. Queste caratteristiche non ci permettono di avere un chiaro consenso su quale sia il miglior programma di esercizi per prevenire e trattare l’osteoporosi. Dall’analisi degli studi è infatti emerso un quadro controverso ma sostanzialmente positivo che avvalora l’efficacia dell’Esercizio Fisico Adattato come valido strumento coadiuvante sia di prevenzione che di trattamento.
Nel complesso possiamo osservare, in base agli studi, che l’esercizio fisico maggiormente utilizzato è quello ad alto impatto (jogging, step, danza, resistance training ed allenamento auxotonico) e quello a basso impatto (camminata, tai chi ricreativo).
La proposta di training
A fronte di tutto ciò, in base all’esperienza come ex atleta di ginnastica artistica e attuale chinesiologo, il vincitore del Premio tesi ISSA 2025 ha voluto descrivere una proposta di training adattato che comprendesse fasi di allenamento ad alto e basso impatto e che prevedesse l’utilizzo della pedana vibrante.
La proposta di training si suddivide in tre parti:
- la fase di riscaldamento (fondamentale per prevenire gli infortuni e per preparare l’organismo ad effettuare il gesto tecnico specifico),
- una fase centrale (che rappresenta il “core” dell’allenamento, dove vengono utilizzati sovraccarichi e bande elastiche),
- il defaticamento (dove vengono proposte le autoposture del Metodo Mézières per lo scarico della colonna e l’allungamento della catena tonico-posteriore).
Fondamentale è effettuare un’anamnesi iniziale con la valutazione della scala di Vas per capire la soglia del dolore delle persone che andremo ad allenare. All’interno della proposta di training sono inserite la pedana vibrante (che può essere utilizzata sia nella fase di riscaldamento sia come seduta specifica di allenamento) e i lavori propriocettivi fondamentali per prevenire la caduta dell’anziano. Questi ultimi si possono eseguire i su piani stabili o instabili a seconda dell’obiettivo.
Conclusioni
Possiamo affermare che non si può individuare un programma di allenamento valido per tutti Gli studi indicano però la rotta da seguire affinché l’esercizio fisico venga programmato e adattato in base alle capacità motorie e allo stato di salute della persona che andiamo ad allenare. Il fine ultimo è che quest’ultimo diventi un’abitudine e uno stile di vita.
Terzo premio Tesi ISSA 2025 a Pierluigi Senor
L’elaborato esplora il ruolo cruciale della Variabilità della Frequenza Cardiaca (HRV – Heart Rate Variability) e del filo conduttore che lega il nostro cuore con la respirazione e il nostro cervello. Diversi studi di livello internazionale, validati e disponibili su PubMed, hanno dimostrato il collegamento tra il ritmo respiratorio e alcuni fenomeni fisiologici quali l’HRV, le onde oscillatorie pressorie arteriose (Onde di Mayer a 0.1 Hz) e i segnali elettrici del cervello.
Ciò avviene rallentando il ritmo respiratorio ad una frequenza di circa 0.1 Hz (6 atti respiratori al minuto). Questa respirazione viene definita Coerenza Respiratoria (CB – Coherence Breathing). La maggior parte degli studi di ricerca effettuati è stata svolta con esercizi di CB nei quali veniva chiesto ai partecipanti di effettuare sedute di respirazione di durata variabile tra 10 e 30 minuti, da svolgere almeno tre volte a settimana, con una durata sia dell’inspirazione che dell’espirazione di 5 secondi ciascuna.
L’impegno richiesto per questi studi spesso portava i partecipanti ad abbandonare o a non riuscire a svolgere tutte le sessioni correttamente.
Studio a breve termine dell’impatto della coerenza respiratoria sull’HRV e sul benessere psicofisico
In questo lavoro sperimentale si è provato ad integrare gli studi sulla CB con quelli del Pranayama (antica filosofia indiana legata allo Yoga e al controllo del Prana, l’energia vitale), elaborando un protocollo di CB fattibile e non troppo oneroso in termini di tempo. Si è chiesto ai partecipanti allo studio di effettuare almeno 10 sessioni di CB.
In 30 giorni, della durata di 10 minuti (suddivisibili in sessioni brevi da 5 minuti), è stato adottato un tipo di respirazione leggermente diverso rispetto alla maggior parte degli studi analizzati su PubMed. Si è data enfasi all’espirazione rispetto all’inspirazione. Infatti veniva richiesto di inspirare per 4 secondi (IN) ed espirare per 6 secondi (ES), utilizzando preferibilmente una respirazione diaframmatica.
L’ipotesi del protocollo proposto è stata quella di poter ottenere miglioramenti tangibili e misurabili sul benessere psico-fisico delle persone con un impegno minimo in termini di tempo, analizzando sia le variazioni percentuali dell’HRV (nel dominio del tempo) sia i feedback psicofisici, prima e dopo il periodo di studio della durata di 30 giorni.
Il campione dello studio
Il campione di popolazione in analisi, composto da 64 persone, è stato diviso in tre gruppi sperimentali con caratteristiche omogenee quali fascia d’età e stile di vita.
- Gruppo “Scuola” (14 persone con età media di 12,8 anni)
- Gruppo “Pilates” (14 persone con età media di 53 anni)
- Gruppo “Misto” (22 persone con età media di 41,9 anni)
- Gruppo di “Controllo” (14 persone con età media di 55,46 anni) per validare la ricerca e gli strumenti utilizzati per misurare l’HRV.
I tre gruppi sperimentali (50 persone) hanno seguito il protocollo di CB, effettuando 10 sessioni di Coerenza Respiratoria da 10 minuti a 0.1 Hz (4” IN e 6” ES) in 30 giorni.
I partecipanti al gruppo “Pilates”, oltre alle sessioni di Coerenza Respiratoria, hanno effettuato due lezioni di Pilates Matwork di gruppo a settimana della durata di un’ora, svolgendo durante ogni lezione almeno 5 minuti di CB.
La misurazione
In sintesi, lo studio è consistito nella misurazione dei dati dell’HRV su tutti e 64 i partecipanti (con età compresa tra 12 e 92 anni), valutando i suoi indici nel dominio del tempo (SDNN, RMSSD e pNN50) prima e dopo il periodo di 30 giorni, effettuando le misurazioni tramite fascia da braccio (Coospo HW807) con tecnologia PPG (fotopletismografia) e utilizzando il software a pagamento Welltory, in grado di fornire l’HRV ottenuto tramite algoritmi validati. I dati sono stati storicizzati su un database relazionale SQL Server ed analizzati con query SQL.
Tutti i partecipanti alla sperimentazione hanno compilato due questionari (uno iniziale e uno finale), nei quali dovevano dare un punteggio di autovalutazione sulla qualità del sonno, lo stress e l’energia (prima e dopo), indicando alla fine della sperimentazione il numero di sessioni di CB Coerenza Respiratoria (CB – Coherence Breathing). effettuate e un feedback psicofisico legato alla pratica della CB.
Dei 50 partecipanti alla sperimentazione, 44 persone (quasi il 90% del campione di popolazione) hanno effettuato correttamente il numero di sessioni di CB richieste (con un tempo medio in 30 giorni di 98 minuti nel gruppo “Scuola”, 115 minuti nel gruppo “Pilates” e 128 minuti nel gruppo “Misto”).
Si sono esclusi sei partecipanti perché non hanno effettuato il numero di sessioni richieste.
L’analisi
Analizzando i dati sugli indici dell’HRV nel dominio del tempo, si è avuta la conferma dell’impatto della Coerenza Respiratoria sull’HRV, rilevando miglioramenti in tutti e tre gli indici indagati (SDNN, RMSSD e pNN50). I miglioramenti percentuali sono compresi tra +4 e +24% per l’SDNN, +6 e +27% per l’RMSSD e +0.5 e +33% per il pNN50. Gli incrementi maggiori si sono avuti per il gruppo “Pilates” (SDNN +24%, RMSSD +27%, pNN50 +33%), indicando come il binomio Coerenza Respiratoria–Pilates possa essere ancora più efficace.
I miglioramenti
I miglioramenti ottenuti per i gruppi sperimentali sono stati confermati dall’analisi dei dati sugli indici dell’HRV del gruppo di controllo, poiché i valori sono rimasti simili o sono leggermente calati nel periodo.
Riguardo all’analisi dei feedback psicofisici dichiarati dai partecipanti ai gruppi sperimentali, l’85% delle persone ha dichiarato di aver percepito miglioramenti su stress (65%), controllo del respiro (56%) e qualità del sonno (32%).
Infine, due settimane dopo la fine dello studio, si è chiesto ai partecipanti alla sperimentazione di indicare se avessero intenzione di continuare a praticare le sessioni di Coerenza Respiratoria anche una volta concluso il periodo di studio. Il 92% delle 37 persone che hanno compilato il questionario ha dichiarato di voler proseguire con il protocollo di Coerenza Respiratoria proposto. Idea è che è preferibile effettuarlo prima di addormentarsi (oltre il 50% di chi ha risposto) o in caso di nervosismo (35%).
Conclusioni
In conclusione, è possibile affermare di aver raggiunto i principali obiettivi preposti. Si sono ottenuti miglioramenti tangibili e misurabili sia nei valori dell’HRV (nel dominio del tempo) sia nel benessere psicofisico delle persone partecipanti alla sperimentazione. A quest’ultime si è trasmessa un’importante metodologia con basi scientifiche e con la capacità di migliorare il benessere delle persone dall’età scolare alla terza età. Con soli pochi minuti di pratica corretta della Coerenza Respiratoria e ponendo l’attenzione sull’inspirazione e sull’espirazione consapevole con tempi prestabiliti, si riesce a creare una risonanza tra la respirazione, il cuore e il cervello.
Iscrizione al Premio Tesi ISSA Europe 2026
Per qualsiasi informazioni clicca qui.